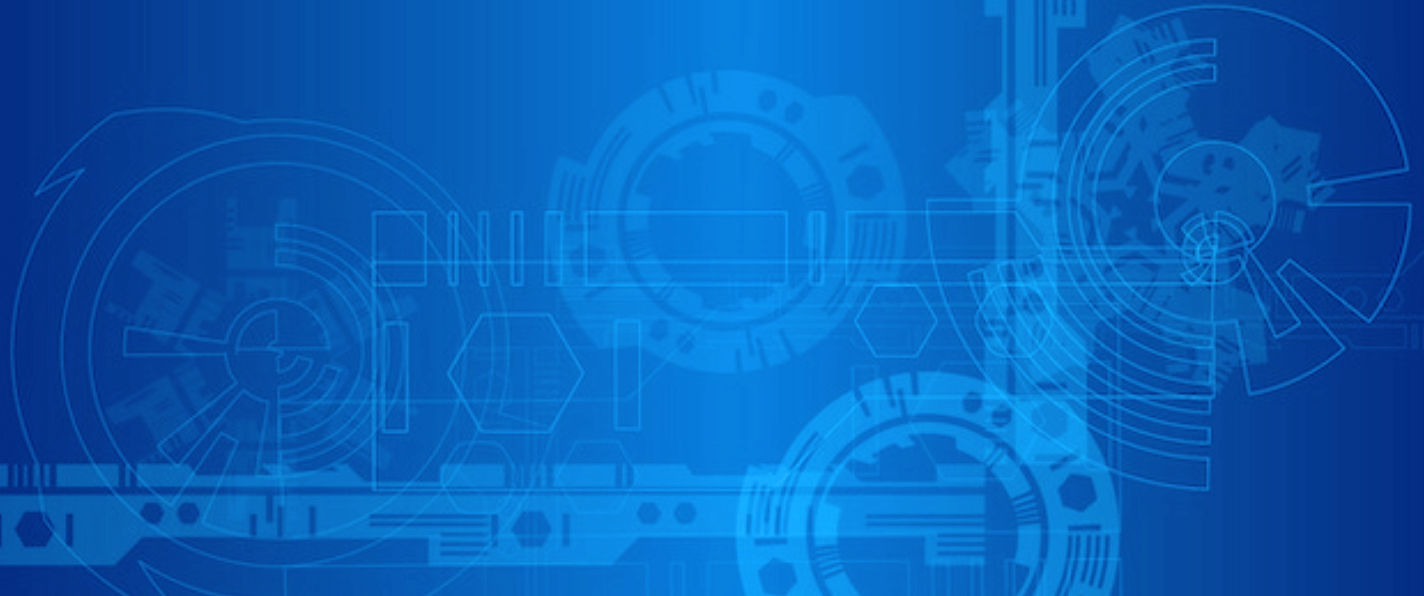Si fa fin troppo in fretta a dire smart working
L'emergenza coronavirus e in particolare il lockdown hanno messo molte aziende e altrettanti dipendenti nelle condizioni di sperimentare pregi e difetti del lavorare fuori dall'ufficio: un'esperienza istruttiva per il futuro ma che, in parecchi casi, poco ha avuto a che fare con lo smart working vero e proprio. Quali allora le sorti del lavoro agile dopo COVID-19?
Tra le conseguenze della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sancita lo scorso 30 luglio, non si può non citare - per quanto riguarda l’ambito specifico del lavoro - anche la possibilità di continuare a far ricorso fino al 15 ottobre allo smart working in forma semplificata, vale a dire adempiendo a una comunicazione amministrativa più “agile” rispetto a quella normalmente prevista e, soprattutto, a prescindere dall’esistenza di un preciso accordo tra le parti in causa. Di pari passo, viene prolungato insieme allo stato emergenziale anche il diritto prioritario di accesso al lavoro agile ad alcune particolari categorie di dipendenti (ad esempio, lavoratori disabili o dipendenti che abbiano all’interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità), così come via via stabilito nel corso degli ultimi mesi dai diversi provvedimenti in materia: unica eccezione quella dei genitori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, per i quali la priorità sancita dal cosiddetto decreto Rilancio viene sì ribadita, ma solo fino al 14 settembre, con evidente riferimento alla ripresa della attività didattiche.
E una domanda sorge allora inevitabilmente spontanea: cosa ne sarà dello smart working una volta superate queste scadenze o, più in generale, una volta cessato l’allarme coronavirus?
L’Italia in lockdown: non smart ma home working
Per rispondere occorre prima di tutto fare un passo indietro. Nel corso della pandemia, e ancor di più durante i mesi più critici non solo dal punto di vista sanitario ma anche socio-economico, quelli del lockdown, la possibilità – quando e dove applicabile - di svolgere le proprie mansioni professionali da casa ha rappresentato un’opportunità enorme. Tanto per i datori quanto i dipendenti stessi, che hanno potuto così scongiurare il blocco totale delle proprie attività minimizzando i rischi di contagio. Descrivere questo periodo come una massiccia sperimentazione di smart working come fatto da più parti, politica e mass media inclusi, è tuttavia piuttosto improprio, perché non di vero lavoro smart si è trattato. Se nella migliore delle ipotesi quello praticato è (stato) un lavoro agile “imposto” o comunque “forzato” considerato il venir meno del presupposto fondamentale dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente, che pur si può immaginare in linea di massima favorevole all’idea di lavorare a casa in condizioni di maggiore sicurezza, in molti dei casi vissuti nel corso della fase emergenziale più acuta sarebbe in realtà più opportuno parlare di home working, se non addirittura di telelavoro. Alla mancata volontarietà dei dipendenti nella pratica dell’approccio smart si è infatti spesso affiancata anche l’impossibilità di scelta dei luoghi – quasi inevitabile, del resto – e soprattutto dei tempi del lavoro, che dello smart working è una condizione basilare.
Nonostante i termini siano con una certa ricorrenza utilizzati come se fossero perfettamente interscambiabili tra loro, telelavoro e smart working (o lavoro agile che dir si voglia) non sono infatti istituti del tutto sovrapponibili, né per filosofia di fondo né per normativa di riferimento. Al più, e comunque semplificando la questione, si potrebbe dire che il secondo nasce come evoluzione, nella direzione di una maggiore flessibilità, del primo che prevede(va) ancora postazioni fisse dalle quali svolgere il proprio lavoro. Al contrario dello smart working, che non si accontenta di mansioni professionali svolte lontano dall’ufficio ma che si fonda innanzitutto su una diversa organizzazione dell’attività lavorativa, un approccio flessibile e indipendente nella scelta di tempi, spazi, modalità e strumenti di lavoro, a propria volta basato su un rapporto azienda e lavoratore votato alla valutazione della performance professionale e alla misurazione dei risultati ottenuti. A prescindere, ad esempio, dalla presenza in una determinata sede o dal rispetto dei canonici “orari d’ufficio”. Una vera e propria “rivoluzione” che, più volte, nell’ambito delle proprie rilevazioni annuali, l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha evidenziato avvenire nell’Italia pre COVID-19 non senza intoppi e con una penetrazione in crescita ma ancora limitata rispetto al potenziale: a causa – tra gli altri - di limiti normativi (ancora da chiarire fino in fondo, ai fini di un’adeguata regolamentazione, alcuni snodi fondamentali come quelli relativi il “diritto alla disconnessione” o quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro), burocratico-amministrativi e tecnologici, ma anche storici e culturali, forse ancora più accentuati in un Paese il cui tessuto produttivo è prevalentemente costituito da imprese piccole e medie dimensioni.
Cambiare il luogo di lavoro non basta: lo smart working dopo il coronavirus
Insomma, se si può dire con certezza che COVID-19 ha avuto sicuramente il merito di porre lo smart working al centro dell’attenzione e della discussione, bisogna essere più cauti nell’affermare che ne ha accelerato la diffusione. Pur non mancando buone pratiche anche a livello nazionale - come aziende che già vi facevano ricorso e hanno deciso di estenderne l’utilizzo o casi virtuosi di realtà grandi o piccole che hanno colto l’occasione per rinnovarsi in questa direzione - una parte altrettanto consistente delle imprese coinvolte da questa sorta di sperimentazione forzata si è – legittimamente – limitata a sfruttare lo strumento del lavoro da casa per non interrompere il proprio business. E talvolta anche con soluzioni piuttosto improvvisate che, con l’allentarsi della minaccia sanitaria, sono destinate a lasciare il passo al rientro in ufficio.
In termini di consapevolezza però tornare indietro non si può. Ed è questo che COVID-19 lascia forse davvero in eredità al mondo del lavoro italiano: obbligate dalla situazione, tutte le parti in causa – datori, dipendenti ma anche decisori politici - sono state in una certa misura forzate non solo a stare a casa, ma anche a confrontarsi sul campo con schemi e soluzioni differenti da quelli normalmente adottati nel corso all'interno della loro routine lavorativa. Con esiti che in molti casi potranno essere valutati solo sul lungo periodo. Per le aziende interessate ma meno preparate, è infatti verosimile ipotizzare che la transizione verso il lavoro agile richieda un processo di adeguamento molto più lungo dei mesi che per il momento ci hanno visto convivere con COVID-19. Ad esempio, per attrezzarsi con i giusti device e verificare i propri protocolli di sicurezza informatica, per offrire ai dipendenti la necessaria formazione o, ancora, per favorire quella trasformazione dei propri modelli manageriali necessaria alla riorganizzazione del lavoro su tutti i livelli, per sviluppare politiche di engagement, per implementare gli accordi individuali e collettivi delle parti dei quali – cessata l’emergenza – sarà impossibile fare a meno.
Solo il tempo ci dirà insomma se sarà smart working per scelta… e non per emergenza.
Mara Guarino, Itinerari Previdenziali
7/9/2020