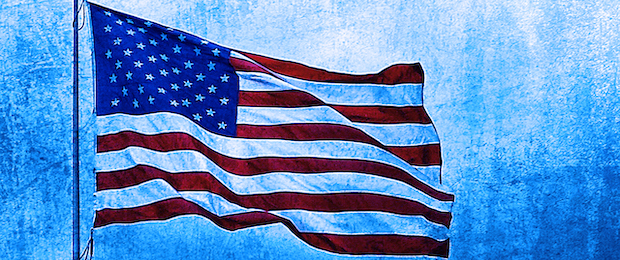Usa (e getta): da Trump a Biden, cambierà tutto?
Gli States sono divisi, ma questa non è una novità: perché allora auspicare un cambio di rotta su tutta la linea? Molti gli elementi che suggeriscono in realtà una transizione meno traumatica di quanto si possa immaginare
Nelle numerosissime analisi dell’esito elettorale delle presidenziali americane, uno dei giudizi più ricorrenti è che il voto lasci in eredità un Paese spaccato in due. Sono molte le evidenze addotte: numeriche, come l’esile divario percentuale dei consensi ricevuti, 50,8% per Biden e 47,4% per Trump; territoriali, come dimostra la mappa rossa nelle zone rurali e blu in quelle urbane; “personali”, dato l’abisso che separa i due candidati sia in termini di stile che di visione politica.
È indiscutibile la validità di questa osservazione. È da capire, invece, se sia questo l’aspetto primario su cui concentrarsi: il divario tra vincitore e sconfitto, a dire il vero, non è poi così esile, sia in senso percentuale (dal 1960 a oggi in ben 6 elezioni si è avuta una distanza percentuale minore) sia soprattutto in termini assoluti (al momento, ci sono circa 6 milioni di voti di differenza); la frattura città-campagna, poi, è un tema centrale ma tutt’altro che nuovo, se si pensa che già alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso era inserita nelle teorie dei politologi; inoltre, la polarizzazione dell’elettorato non è certamente un’esclusiva del popolo a stelle e strisce. Le numerose elezioni in Italia e nel resto del mondo hanno testimoniato negli ultimi anni una spaccatura sempre più evidente, che poggia certamente su elementi profondi e radicati ma che, almeno nelle urne, non ha certamente prodotto cristallizzazione, considerata la notevole fluidità dei flussi elettorali.
La spaccatura della popolazione, dunque, non sembra offrire indizi sui quattro anni che ci aspettano. Anzi c’è, forse, un’altra “spaccatura” più interessante da sottolineare, ossia quella che potrebbe insinuarsi nella stessa presidenza di Joe Biden: vale a dire la spaccatura tra il dire e il fare, tra la comunicazione e l’azione, tra le firme sui decreti e quelle sui tweet. Alcuni elementi lasciano pensare che a una comunicazione tanto roboante, all’annuncio di una rivoluzione accompagnata da squilli di tromba e schiere esultanti, segua poi una gestione molto più pragmatica, certamente non incanalata nel solco di quella trumpiana, ma non rivoluzionaria.
L’immagine di Biden, come si è potuto osservare in tutta la campagna elettorale e in questi primi giorni di transizione, virerà esattamente nella direzione opposta di Trump: già nel discorso celebrativo ha puntato su sentimenti distensivi più che aizzanti, parole di unione più che condanna, standing da politico affidabile più che da imprenditore no-matter-what, visione internazionale globalizzata e multilaterale più che isolazionista. Gli assist di Obama, i rumours sulla composizione multi-tutto del gabinetto, l’hype generato sui (social) media lasciano spazio a pochi dubbi. Certamente questo non è un cambio da poco: la forma è sostanza, e ancor di più al giorno d’oggi la narrativa, l’immagine e la comunicazione hanno un effetto molto incisivo sulla percezione del potere e del suo decision-making. Per questo, la certezza di un ritornato multilateralismo, l’allentamento della tensione e una maggiore “razionalità” nella gestione della Casa Bianca sono ottime notizie.
È però tutto da dimostrare se ci sarà lo spazio per un’azione politica realmente rivoluzionaria, o quantomeno al livello di quanto si voglia far passare. Ci sono alcuni elementi che sembrano suggerire che, soprattutto fino alle elezioni di mid-term tra due anni, il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America non farà tutto, ma nemmeno gran parte, di quello che molti si aspettano.
Innanzitutto, un conto è vincere le elezioni, un altro governare: per il primo atto servono i voti nelle urne, e Biden li ha presi, per il secondo quelli nel Congresso, e lì è già più in difficoltà. Per quanto riguarda la Camera, il partito del Presidente ha 219 seggi, mentre quello di Trump ne ha 203; tuttavia nel Senato, al momento, i democratici detengono 48 seggi, mentre i repubblicani 50: ne restano due da assegnare in Georgia, nel ballottaggio del 5 gennaio: avere due camere di colore opposto sarebbe già di per sé un forte freno al mandato di Biden, che dovrebbe dire addio a riforme profonde a favore di interventi più concertati e frutto di compromessi.
Il secondo aspetto fa leva sulla scarsa unità del partito democratico. La tregua per la campagna presidenziale è terminata subito, con le dichiarazioni al vetriolo di Alexandra Ocasio Cortez, giovane progressista tutt’altro che moderata e desiderosa di crescere e guadagnare consenso; oltre a lei sono numerose le anime interne del partito, e per Biden non sarà facile fare una sintesi di tutte le istanze.
Il terzo elemento forse è più difficile da accettare per i democratici: non tutto quello che ha fatto Trump è stato negativo. Fino a prima della pandemia di COVID-19, l’amministrazione poteva vantare ottimi risultati economici, come ad esempio il boom della Borsa o un indice di disoccupazione che aveva toccato minimi storici mai raggiunti dagli anni Settanta; inoltre, gran parte dell’attenzione oltre confine è stata dedicata alla Cina, contrastandola duramente nella sua ambizione di potenza globale, come si è visto in occasione delle guerre commerciali o del boicottaggio dell’espansione di Huawei in Europa; o ancora, per quanto tutti da verificare, i passi fatti in Medio Oriente con gli accordi tra Israele e alcuni Paesi arabi sono incoraggianti. Sono solo alcuni spunti che suggeriscono come un’inversione a U su tutta la linea possa avere dei limiti.
Infine, lo stesso standing di Biden sembra suggerire una gestione di transizione più che di rivoluzione, probabilmente tirando la volata nel 2024 alla prima presidenza femminile della storia, che sia di Kamala Harris o di un’altra sfidante (magari la stessa Ocasio Cortez?).
Ovviamente, tutto questo non significa che non ci sarà una marcata distanza anche operativa tra le due presidenze: si pensi solo al tema ambientale, con Trump intento a demolire quanto fatto da Obama in tema di attenzione all’ambiente (lo scorso 5 novembre sono formalmente usciti dall’accordo di Parigi del 2016), e con i democratici che non vedevano l’ora di tornare a dipingere di green la Casa Bianca. Il punto è quanto velocemente Biden riuscirà a virare la rotta di quella che non è una barca a vela, ma un gigantesco transatlantico: per restare nella sostenibilità, un varco al quale aspettare il nuovo presidente, misurandolo su file “concreti” e non solo “di alto respiro”, sarà proprio il tema degli investimenti dei fondi pensione, visto che recentemente il Dipartimento del Lavoro ha emesso una final rule che obbliga i fiduciari degli investimenti dei piani dell’ERISA (Employee Retirement Income Security Act) a escludere criteri non "pecuniari” (in sostanza, o un investimento ESG è palesemente più redditizio – e bisogna dimostrarlo con l’onere della prova – oppure sarà vietato preferirlo ad altri).
Insomma, è tutto da verificare se è iniziata una nuova era o se, alla fine, assisteremo a un “gattopardesco” tutto cambia perché nulla cambi.
Giovanni Gazzoli, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
23/11/2020