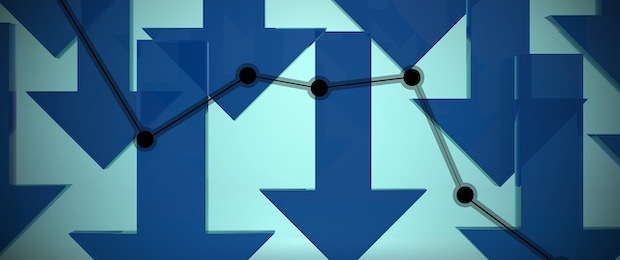TFR vs BTP, un confronto possibile?
Tensioni nei mercati, aumento dello spread, rendimento dei fondi pensione in flessione; temi di copertina in questo periodo per quotidiani e programmi televisivi che riportano alta l’attenzione anche sul confronto tra chi ha scelto di aderire alla previdenza complementare e chi, invece, di tenere il TFR in azienda
Molti studi, ricerche e articoli sono stati fatti e si faranno per confrontare pro e contro sulla scelta di aderire alla previdenza complementare. Nonostante ciò, appena i rendimenti dei fondi pensione registrano una flessione (come si vede proprio in questo periodo), gli iscritti tornano a chiedersi se hanno fatto la scelta giusta e non fosse stato meglio, al contrario, lasciare il TFR in azienda proprio come, magari, ha fatto qualche collega. Questo approfondimento non vuole aggiungere nulla a quanto già scritto ma ha l’obiettivo di porre una riflessione, mista a una leggera provocazione: il rendimento riconosciuto per legge al TFR è da considerarsi “equo”?
La legge del 25 maggio 1982 n.297 ha regolamentato il trattamento di fine rapporto (TFR) attraverso una modifica dell’art. 2120 del codice civile per disciplinare, oltre alla modalità di calcolo, il coefficiente di rivalutazione; una previsione nata con la evidente ratio di “proteggere” il TFR dall’inflazione che, in quel periodo, era a doppia cifra. Dal secondo semestre del 2007 questo meccanismo di protezione viene utilizzato come benchmark per il rendimento dei fondi pensione. In questo senso (sotto il “puro” aspetto finanziario) proviamo a capire se il tasso di rivalutazione può considerarsi “equo”, almeno con riferimento ai lavoratori delle aziende del settore privato con più di 50 dipendenti (circa il 50% della forza lavoro in Italia) obbligate al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS (istituito con la legge finanziaria 2007) per i dipendenti che non abbiamo attivato la previdenza complementare.
In questo caso possiamo affermare che i dipendenti “prestano” il loro TFR allo Stato; una sorta investimento nel continuo del rapporto di lavoro e il cui rendimento dovrebbe essere al correlato, sotto l’aspetto di vista finanziario, principalmente al:
- periodo di investimento (più lungo è l’investimento maggiore sarà il rendimento atteso);
- rischio di fallimento del creditore.
La prima grandezza è legata al periodo di lavoro all’interno della stessa azienda, un dato molto eterogeneo in Italia che, per le aziende con più di 50 dipendenti, può essere stimato a circa 26 anni[1] durante i quali l’azienda versa il TFR al fondo di tesoreria e lo Stato provvederà a rivalutarlo, di anno in anno: una sorta di PAC con durata media di 13 anni, e il cui rendimento, per l’anno 2017, è stato pari al 2,10% lordo (1,74% netto tassazione 17%).
Il secondo fattore è rappresentato dal rischio che lo Stato italiano fallisca: il mercato prezza questo rischio a 13 anni (stessa durata del PAC) al 3,57%[2] lordo (3,12% al netto della tassazione 12,50%): in questo senso il rischio finanziario non sarebbe adeguatamente remunerato (2,10% previsto per legge contro 3,57% richiesto dal mercato). Le stesse considerazioni effettuate un anno fa, di questo periodo, ci avrebbero portato a dire che il rendimento del TFR era da considerarsi adeguatamente remunerato (rendimento netto a 13 anni dei titoli di stato 1,88%, rendimento del TFR 1,80%): quale delle due risposte, a questo punto, possiamo considerare corretta? Probabilmente nessuna delle due; il legislatore ha previsto una “protezione dall’inflazione” in quanto il TFR era visto come una quota di “reddito differito”.
Chi è iscritto alla previdenza complementare, dunque, dovrebbe cercare di non cadere nella “trappola” di paragonare la rivalutazione del TFR al rendimento del suo fondo pensione: sono due strumenti profondamente diversi (anche sotto l’aspetto fiscale) che mal si prestano a essere confrontati sotto l’aspetto finanziario ancor di più se si considera solo il breve periodo.
Nicola Barbiero
17/12/2018
[1] La pubblicazione “Il mercato del lavoro: una lettura integrata – 2017” (Rapporto frutto del lavoro congiunto del gruppo di lavoro tecnico e del comitato d’indirizzo dell’accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal) riporta che le aziende con più di 50 dipendenti registrano un tasso di uscita annuo pari tra 4,6% (aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249) e 3,3% (aziende con più di 250 dipendenti) con una media ponderata (sulla porzione di aziende sul totale attive) del 3,78% il cui inverso ci dà indicazione di quanti anni un dipendente lavora, in media, per la stessa azienda (circa 26 anni)
[2] Dato ottenuto per interpolazione dal rendimento dei titoli di stato italiani strumenti con scadenza 10 anni (3,449%) e 15 anni (3,653%). Alla data del 23/11/2018 questo corrisponde a 3,57% lordo (Fonte: it.investing.com)