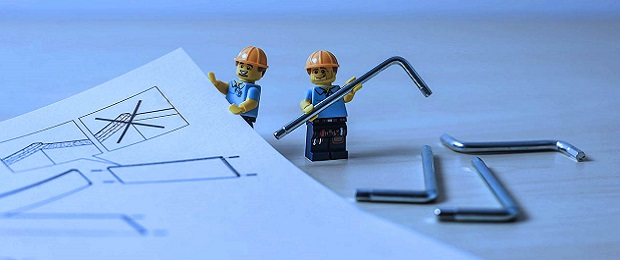Occupazione e luoghi comuni: falsificare la realtà non serve a nessuno
Il report dell'Istat sul terzo trimestre 2021 fa chiarezza sulla consistenza della ripresa dell'occupazione e smentisce alcuni recenti luoghi comuni su precariato, retribuzioni e ricorso al part-time. Gli stessi dati evidenziano però l'urgenza di una riflessione sulla difficoltà delle aziende a trovare personale
Alcune recenti valutazioni incorporano una forte dose di scetticismo verso la reale consistenza e la qualità della ripresa economica, che si appunta non tanto sugli indicatori macroeconomici quanto sui temi dell’occupazione e delle retribuzioni. Si tratta però prevalentemente di una posizione condizionata da imprecisione, errata valutazione dei dati e delle loro relazioni, acritica adesione a luoghi comuni.
La pubblicazione dei report Istat sul mercato del lavoro nel terzo trimestre, e nel mese di ottobre, e quello di Bankitalia sulle comunicazioni obbligatorie per lo stesso periodo possono aiutare a fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto sale l’occupazione, ma questo è un fatto noto e conclamato: un trend consolidato da tempo, anche se per raggiungere i livelli pre COVID mancano ancora circa 200mila occupati. Che non si tratti di un rimbalzo occasionale lo dimostra il dato tendenziale (+2,2% sul terzo trimestre 2020) e quello dell’input di lavoro nel sistema economico, misurato dalle ore lavorate (+4,1% rispetto al 2020, e +1,4% rispetto al trimestre precedente). Eloquente anche il valore delle posizioni lavorative dipendenti, che cresce del 2,7% rispetto al trimestre precedente, e addirittura del 3,3% nell’industria e del 5,8% nei servizi rispetto all’anno scorso. Dove occorre fare un po’ di chiarezza è sulle varianti dell’occupazione dipendente.
Primo luogo comune: è un’occupazione fatta di precarietà
Non è vero, si tratta di un effetto ottico! Semmai, è ben vero che adesso le assunzioni a termine superano quelle a tempo indeterminato, ma per un’ovvia ragione: durante la crisi e il blocco dei licenziamenti le uniche cessazioni di lavoro (a parte dimissioni volontarie o pensionamento) erano quelle dei tempi determinati che scadevano. Naturale, dunque, che non appena gli andamenti economici abbiano concesso alle aziende di riadeguare gli organici, quest'ultime abbiano cominciato col riempire il classico serbatoio di contratti a termine.
Non è d'altra parte affatto vero che i contratti a termine siano aumentati in assoluto: adesso sono al 13% del lavoro dipendente, esattamente come prima della crisi. Come abituale nei periodi di crescita, notevole poi l’aumento del lavoro in somministrazione, +30% rispetto a 12 mesi fa. Occorre in ogni caso ricordare che l’80% dei contratti di somministrazione sono a termine (costituiscono circa il 16% di tutti i contratti a tempo determinato) ma 100.000 lavoratori somministrati sono a tempo indeterminato. In definitiva, il luogo comune secondo il quale con la ripresa aumenta la cosiddetta precarietà è del tutto infondato. E a latere ci sarebbe anche da fare una riflessione seria circa l’equazione lavoro a termine uguale a precarietà...
Secondo luogo comune: è un’occupazione in cui ha un peso enorme il lavoro part-time
Sbagliato! Nella ripresa le assunzioni a tempo parziale crescono significativamente di meno: negli ultimi 12 mesi le posizioni lavorative full-time sono cresciute del 5,6%, quelle part-time del 3,6%. I’incidenza dei part-timer sul totale del lavoro dipendente a tempo indeterminato è dell'11,2%, mezzo punto inferiore a 12 mesi fa. Del resto, una minor incidenza del lavoro part-time, ancorché marginale ma significativa perché tendenziale, è rilevabile dal dato delle ore lavorate pro capite, che cresce del 3,3% in termini congiunturali (mese su mese) e del 2,7% tendenziale (ultimi 12 mesi).
Resterebbe poi da fare un’indagine seria sul part-time “involontario”: per Eurostat la definizione si applica a lavoratori che vorrebbero passare a full-time, e secondo questa definizione il Italia il 15% dei dipendenti part-time sono in questa condizione; i ricercatori italiani invece tendono ad adottare criteri che considerano se il part-time sia stata una richiesta del lavoratore o una proposta dell’azienda e, in questo caso, gli involontari arrivano intorno al 40%.
Terzo luogo comune: le retribuzioni diminuiscono a causa della pandemia
Non è così! Ovviamente nel 2020 è calato il monte salari, dal momento che è diminuito il numero degli occupati. Così come nei mesi del lockdown e in quelli immediatamente successivi le medie delle retribuzioni sono calate, ma solo per effetto della cassa integrazione. Viceversa, a partire dal 2008 e fino al 2019, Eurostat ci informa che gli stipendi medi lordi sono cresciuti di circa il 3%, in linea con la media UE. Diverso il discorso se si prendono in considerazione i salari netti e le diverse fasce di reddito: per quella sui 16mila euro annui il netto è cresciuto di 7,4 punti (grazie soprattutto al “bonus Renzi”), per quella tra 50.000 e 55mila è diminuito di 3 punti! Ma questa fascia di lavoratori, come abbiamo imparato dal recente dibattito, non sta particolarmente a cuore al sindacato! [Attenzione, i dati sono riferiti ad un monoreddito senza figli, escludono quindi detrazioni e benefici che sono più rilevanti nelle fasce di reddito basse].
Naturalmente, parlando di andamento delle retribuzioni, occorre tenere in conto il valore reale, quindi il potere d’acquisto. Secondo Job Pricing il periodo 2014-2019 ha visto le retribuzioni globali di fatto crescere significativamente più dell’inflazione: tra il 5% dei quadri e l’8% degli operai. Tuttavia questo trend favorevole era relativo a un’inflazione minima, se non negativa, che si è bruscamente rialzata nella seconda metà del 2021. Alla fine del terzo trimestre (dati Istat) le retribuzioni erano cresciute dell'1,7% ma l’inflazione del 2,6%. Per il 2022 comunque l’80% dei lavoratori è coperto da CCNL rinnovato che prevede aumenti retributivi mediamente dell'1,2%.
Questo indica abbastanza chiaramente qual è il punto sulla questione retributiva: i salari sono bassi, e reggono solo finché l’indice dei prezzi è basso anch’esso. Risulta però altrettanto evidente che il sindacato non può pensare di aumentare i salari operando soltanto su sgravi fiscali e contributivi, per quanto importante possa essere il cuneo (che peraltro ha effetti negativi sul costo del lavoro più che sulla retribuzione netta). Sarebbe utile fare un raffronto serio sulle retribuzioni italiane di fatto e quelle europee, considerando anche istituti come la tredicesima, la quattordicesima, il TFR e il sistema di sostegni al reddito finanziato da imprese e lavoratori. Tuttavia non c’è dubbio che le retribuzioni italiane siano nella fascia bassa dell’UE; del resto, la produttività dei fattori, lavoro compreso, è tra le più basse in Europa.
Su questo terreno si gioca la partita dei salari, purchè il sindacato sia capace di coniugare le rivendicazioni a intese sugli altri fattori che condizionano la produttività: apertura alla concorrenza e fine del monopolio nei servizi pubblici, revisione dei sistemi di autorizzazione-controllo sulle iniziative imprenditoriali private e pubbliche, riforma del sistema giudiziario penale e civile e revisione delle competenze della giustizia amministrativa, rinnovamento profondo della Pubblica Amministrazione (dalle modalità di reclutamento del personale alla ridefinizione della sua mission verso la società).Tutti argomenti su cui si sofferma malvolentieri ma che, in questo momento, con il Recovery Plan da articolare e attuare, rappresentano un’occasione impedibile per un sindacato che voglia inserire il tema delle retribuzioni in un progetto di riordinamento del sistema Paese.
Perché urge una riflessione sui posti vacanti
Un ultimo aspetto dei recenti report sui quali le varie sigle non hanno ancora affrontato una riflessione organica: Istat dice che il tasso di posti vacanti - assunzioni programmate che restano inevase per mancanza di candidati adeguati - è nel terzo trimestre del 2%, raddoppiato rispetto all’anno scorso. Ossia, come del resto più volte segnalato da numerose ricerche, al crescere della domanda di lavoro in connessione con la ripresa non corrisponde un aumento dell’offerta. E questo spiega in buona partele difficoltà a recuperare l’occupazione pre COVID, ma più in generale l’endemico basso tasso di occupazione del Paese. Tuttavia il Sindacato, pur comprensibilmente preoccupato di evitare licenziamenti, non sembra dare la necessaria attenzione alla promozione di nuova occupazione.
Ma il tasso di licenziamento del 2021 (dati Banca d'Italia) è addirittura inferiore alla metà di quel che era all’inizio del 2019. Con la fine del divieto di licenziamento a ottobre c’è stato un picco, come temuto, ma subito riassorbito. I licenziamenti sui quali si concentra attualmente l’attenzione dei sindacati e dei media non segnano in realtà nessun aumento rispetto a quello che è il trend storicamente consolidato, anche se dal punto di vista mediatico alcuni episodi, soprattutto quando vedono protagonisti investitori stranieri, hanno avuto molto clamore.
Certo, non è molto coerente diffondere un’informazione che enfatizza alcuni casi, per gravi che siano, per alimentare la convinzione che ci sia una tempesta di licenziamenti ed evitare di dire che, nel complesso, i licenziamenti non sono quanti si temeva, e che comunque diminuiscono.
Silenzio invece sul problema prima indicato il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sul quale, come sulle prospettive dei giovani nel mercato del lavoro, vengono unicamente spese parole di corrucciata preoccupazione; e allorché si affronta la questione che potrebbe dare risposte a questo problema, ossia le politiche del lavoro, il sindacato sceglie di privilegiare una linea difensiva preoccupandosi principalmente di chiedere ammortizzatori sociali che garantiscano il reddito agli occupati. Un’esame di realtà e la ricerca di soluzioni costruttive sarebbero utili per tutti.
Claudio Negro, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Fondazione Anna Kuliscioff
29/12/2021